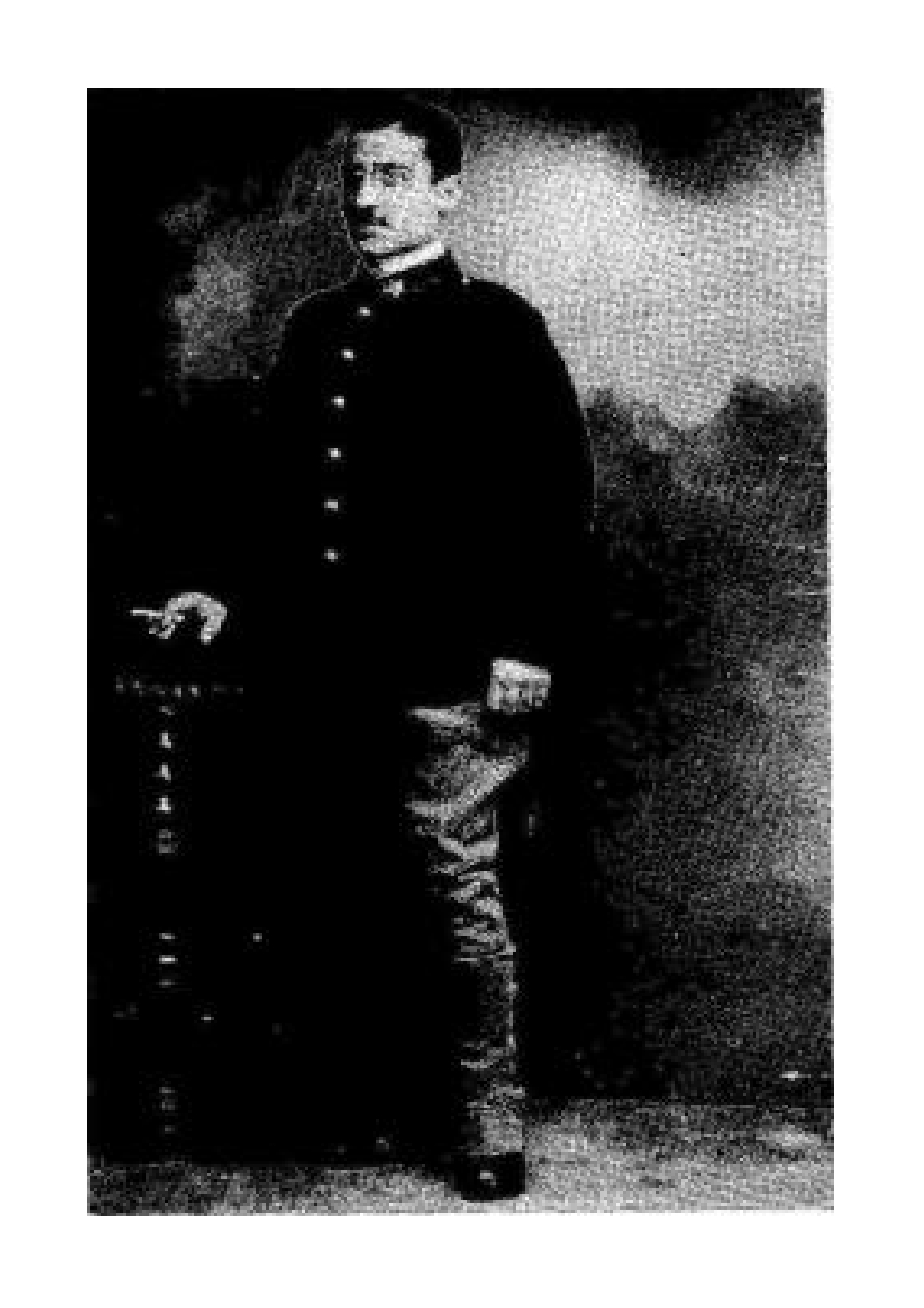Dopo la fine della Grande guerra, in Sicilia si diffuse sempre più il movimento dei contadini per l’occupazione delle terre. In quel periodo (1918-1920), la maggior parte dei lavoratori era costituita da braccianti agricoli con salari da fame, che lavoravano dall'alba al tramonto. I braccianti (jurnatara) lavorano le terre dei grandi affittuari (gabelloti) che avevano al loro servizio una folta schiera di campieri. Su ogni bracciante gravavano vari tributi di origine feudale, che venivano pagate al campiere in cambio di "protezione".
Ora, grazie ai partiti politici e alle aggregazioni sindacali, i contadini tentavano di contrastare l'intermediazione parassitaria della mafia agraria. Nacquero in Sicilia diversi partiti politici, i sindacati divennero fenomeni di massa, le cooperative già esistenti subirono delle grandi trasformazioni. Nuovi orientamenti legislativi avevano reso più possibile l’accesso alla terra da parte dei contadini mediante concessioni prefettizie e senza che fosse necessario il consenso dei proprietari. Con il D .L. 14 febbraio 1918 n. 147, infatti, lo Stato concedeva ai Prefetti la facoltà di potere assegnare le terre, appartenenti ad enti pubblici ed a privati proprietari, alle nascenti cooperative agricole costituite soprattutto da combattenti e dai reduci, e divenute anch'esse un vero o proprio fenomeno di massa.
Lo storico Francesco Renda scrive che “fra il settembre e l'ottobre del 1920 si ebbero occupazioni di feudi in 46 Comuni della provincia di Palermo, in 20 nella provincia di Girgenti”. Fu da questo fenomeno di massa che la cooperazione assunse un carattere nuovo: quello di uno strumento di produzione indispensabile per "accedere alla terra", non fondato sulla libera contrattazione, ma su una legge dello Stato.
In questo contesto, si tennero in Sicilia numerosi congressi regionali dei lavoratori della terra, in cui si confrontarono rappresentanti di leghe contadine, di cooperative agricole e di numerose federazioni socialiste. Nel corso del congresso che si tenne a Catania il 24 ottobre 1920, il P.S.I confermò la sua posizione, e per bocca del suo rappresentante Sebastiano Bonfiglio, dichiarò:
I socialisti sostengono che il latifondo non va spartito. Dev'essere espropriato dai Comuni a cui rimarrà proprietà intangibile. I Comuni dovranno affidarne la coltivazione alle cooperative agricole di cui dovranno fare parte tutti i contadini.
Fu proprio a seguito di questo congresso che anche a Casteltermini si creò un largo movimento contadino per la costituzione di cooperative agricole, guidato dal prof. Giuseppe Zaffuto nella qualità di segretario della Sezione Socialista.
Contemporaneamente, se da una parte si assiste ad un ampliamento a macchia d'olio del movimento per la difesa della terra, dall'altra, come scrive lo storico Umberto Santino, “al termine della grande guerra, in un diffuso clima di violenza politica, in tutta la provincia di Agrigento si era verificata una sistematica campagna di intimidazioni, aggressioni alle camere del lavoro, distruzione dei centri di aggregazione socialista, popolare e sindacale”.
La mafia fu abile a creare una nuova rete di protettori e complici, legati al regime fascista; in particolare, la mafia agraria locale, da sempre braccio armato dei latifondisti, dei gabelloti e dei campieri, intimorita dalle richieste del movimento contadino, aveva stabilito un patto di ferro con l’ambiente squadrista/nazionalista/fascista.
Il 20 novembre 1920 veniva riconosciuto ufficialmente il Fascio di Combattimento di Agrigento, e il 4 dicembre quello della vicina Canicattì.
26 dicembre 1920
Il 26 dicembre 1920, quattro persone incappucciate, rimaste sconosciute, lanciarono una bomba all'interno della sezione socialista di Casteltermini, in quel momento piena di militanti. Oltre a numerosi feriti, l'esplosione provocò la morte del prof. Zaffuto e di quattro contadini iscritti al partito.
Giuseppe Zaffuto, segretario della sezione socialista e insegnante di calligrafia presso la Regia Scuola Tecnica e Normale di Agrigento, morì sul colpo. Carmelo Minardi, contadino, si spegnerà poco dopo all'ospedale dello Spasimo di Palermo dove era stato trasportato. Il contadino Salvatore Varsalona, sposato con Caterina Tagliarino, morì il giorno dopo nella sua casa, e non ricoverato in ospedale, perchè intrasportabile. Molti anni dopo, nel 1988, suo nipote Filippo diventerà sindaco di Casteltermini.
Successivamente, per le ferite riportate, moriranno anche i contadini Calogero Faldetta, che si spense il 31 dicembre 1920 presso la clinica Orestano di Palermo, e Gaetano Circo, sposato con Maria Lo Presti, che morì il 4 febbraio 1921 presso l'Ospedale Civico di Palermo, dove era stato trasportato.
Numerosi furono i feriti, tra i quali Gaetano Spoto e Vincenzo Varsalona, che rimasero gravemente invalidi per tutta la vita a causa delle numerose ferite riportate alle gambe.
Vicenda giudiziaria
Dall'accertamento compiuto dai carabinieri, incaricati di indagare sul grave attentato, risultò che l'atto criminale venne compiuto dalla mafia della Valle del Platani, "perché le cooperative agricole socialiste avrebbero provocato la fine dei campieri della mafia che indisturbati imperavano su tutte le campagne e su tutti i proprietari".
Tuttavia, nonostante le indagini accurate dei carabinieri, i responsabili dell’attentato non vennero mai individuati e la strage è rimasta impunita.
Memoria viva
La storia della strage di Casteltermini è ricostruita in alcuni libri di storia locale. Tra questi, in particolare “Uomini e fatti di Casteltermini nella storia moderna e contemporanea”, di Francesco Lo Bue, che ricostruisce la storia dell'attentato sulla base di una memoria scritta dal prof. Edoardo Zaffuto, fratello di Giuseppe.
Non conosciamo molto però della vita delle vittime della strage. Vorremmo ricostruirle per permettere a tutti di conoscere che persone fossero, quali le loro passioni, i loro progetti e i loro sogni. Questo renderebbe la costruzione di una memoria collettiva ancora più vitale. Ecco perché continueremo a cercare notizie e testimonianze su di loro e a chiedere il contributo di chiunque possa fornircele.